Roma 31 ottobre 2013
Nadine Gordimer è nata a Springs, nel Transvaal, Africa, nel 1923 da genitori ebrei, russo il padre e inglese la madre.
Ha studiato all’università di Johannesburg, in sud Africa, assistendo al dramma dell’apartheid, della segregazione sociale, della persecuzione politica, dell’oppressione della popolazione di colore da parte della minoranza bianca.
Ha cominciato a scrivere nel 1949 mettendo al centro della propria opera i problemi razziali, le differenze etniche e culturali che si interpongono nei rapporti fra le persone, l’opposizione all’ingiustizia sociale.
La Gordimer rappresenta la realtà quotidiana e ritrae i personaggi nella loro dimensione privata: è proprio lì infatti che si manifesta la violenza esercitata dal potere sui più deboli e contro gli oppositori.
L’autrice, i cui libri sono stati a lungo messi al bando in Sud Africa, ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1991.
Una delle sue opere principali è Qualcosa là fuori, racconto che si inserisce nella nuova tradizione realista contemporanea, prefiggendosi il compito di denunciare una terribile situazione sociale rappresentando le condizioni di vita in un paese autoritario e razzista.
Tuttavia, l’autrice non si limita a “fotografare” quella realtà, a tradurla fedelmente sulla pagina.
La realtà, infatti, non è solo quella esterna, oggettiva, ma anche quella soggettiva dei fatti interiori, dei patimenti subiti, dei drammi della coscienza, dei tormenti morali.
Anche questi eventi fanno parte della situazione storica, anzi ne sono il nucleo principale.
Per sottolineare tale realtà, la Gordimer utilizza un doppio canale di scrittura, differenziato anche dall’uso del corsivo: da un lato il racconto oggettivo in terza persona, il punto di vista in terza persona, dall’altro il racconto soggettivo in prima persona, il punto di vista interno del personaggio in cui l’autrice “entra” ed “esce” di volta in volta partecipando e prendendone le distanze.
“Si contano i giorni solo quando si aspetta un bambino, o si è in prigione. Io l’ho avuta, la mia bambina, ma conto i giorni dall’arrivo di quell’uomo in questa casa.
La strada si tuffa giù tra due file di case come il letto abbandonato in un fiume che ha cambiato corso. La padrona dello shebeen, che abita di fronte, ha una macchina che arriva sbandando e sobbalzando fino all’elaborato cancello di ferro battuto della casa. Tutti gli altri, compresi i clienti dello shebeen , camminano sui sassi, la sabbia i canali di scolo, tornando dalla stazione degli autobus. La città è troppo lontana, per andare a lavoro in bicicletta.”
(shebeen: locale in cui si vendono bevande alcoliche abusivamente)
A domani
Lié Larousse


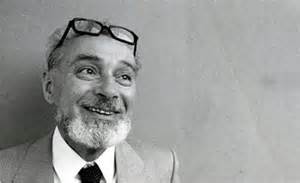

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.